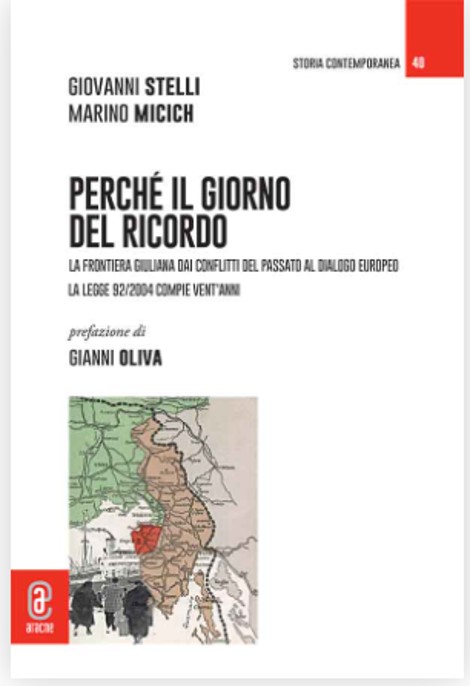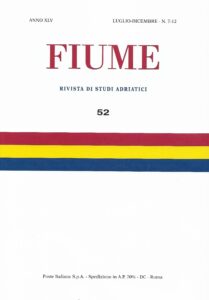Uscito il nuovo libro di Giovanni Stelli e Marino Micich per Aracne Perché il Giorno del Ricordo. La frontiera giuliana dai conflitti del passato al dialogo europeo.
Con la legge n. 92/2004 che venti anni fa ha istituito il “Giorno del Ricordo”, la memoria degli esuli giuliano-dalmati è diventata ufficialmente parte della storia nazionale. La legge invita il 10 febbraio di ogni anno istituzioni statali, enti culturali, scuole e cittadini a ricordare e a studiare il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, nonché le problematiche relative alle complesse vicende della frontiera orientale. Inoltre, il 10 febbraio 2024 il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato la prossima costituzione a Roma di un Museo Nazionale del Ricordo. Un’iniziativa di grande rilevanza e senza precedenti. L’auspicio degli autori è di contribuire all’abbandono definitivo della logica degli schemi ideologici contrapposti sull’argomento, per divulgare una conoscenza di fatti storici liberi da condizionamenti di parte e da interessate omissioni che per lunghi decenni li hanno relegati nell’oblio.
PREFAZIONE
Se in Italia la memoria storica avesse avuto percorsi diversi, le vicende della frontiera adriatica sarebbero state parte delle consapevolezze collettive e non sarebbe stato necessario introdurre nel calendario civile il Giorno del Ricordo del 10 febbraio. Ma la rielaborazione del nostro passato è stata monca, distorta da omissioni, censure e autoassoluzioni che hanno suddiviso gli eventi tra “dicibili” e “indicibili”:
in particolare, sono risultati “indicibili” tutti i riferimenti a ciò che ricordava la sconfitta della guerra.
La storia non è una materia esatta come la matematica o la fisica: è una disciplina fatta di interpretazioni, di ricerca delle fonti, di nuovi documenti che di volta in volta possono correggere o trasformare i giudizi. Alcune cose, però, sono certe: una di queste è che se al termine di un conflitto un Paese si è ingrandito significa che ha vinto, se si è rimpicciolito significa che ha perso. L’Italia che il 10 febbraio 1947 viene ridisegnata dalla Conferenza di pace di Parigi vede il confine nordorientale profondamente diverso da quello del 1939 data di inizio della Seconda guerra mondiale, con un’area vasta abitata da centinaia di migliaia di italiani (l’Istria, Fiume, la Dalmazia, l’Alto isontino
e gli arcipelaghi dell’Adriatico settentrionale) passata sotto la sovranità della Jugoslavia. Dunque, è “storicamente certo” che l’Italia ha perso la guerra: ma quando mai, a scuola, abbiamo studiato sui manuali o sentito spiegare dai docenti che l’Italia ha perso la guerra? Per l’immaginario collettivo, la fine della guerra è il 25 aprile, l’insurrezione delle città del Nord, la liberazione partigiana dopo vent’anni di
fascismo e due di dominazione germanica. Tutto vero: ma se la Resistenza ci mette dalla parte giusta della storia, non è però sufficiente a nascondere le responsabilità collettive del periodo precedente. Come ha scritto un grande storico liberale, Rosario Romeo, “la Resistenza, opera di una minoranza, è stata usata dalla maggioranza degli Italiani come alibi per non fare i conti con il proprio passato”.
Non è questa la sede per ricostruire le ragioni che hanno portato a questa rappresentazione assolutoria, né per analizzare l’urgenza di normalizzazione che ha indotto le forze nazionali moderate a far transitare la classe dirigente dal regime alla repubblica senza indagare sulle tante complicità con la dittatura. Vanno però ricordate le conseguenze di questo atteggiamento sui percorsi della memoria e sulla definizione di ciò che risulta “indicibile”: per legittimare l’idea dell’Italia come potenza vincitrice, non bisogna parlare di prigionieri, perché rinviano per loro natura all’idea di sconfitta (a tutt’oggi non è stato definito il numero esatto dei nostri prigionieri di guerra); non bisogna
parlare delle guerre d’aggressione 1940-43 e fingere che il conflitto inizi con l’8 settembre 1943; non bisogna parlare di crimini e criminali di guerra di un Regio esercito che per tre anni occupa territori nei Balcani, in Grecia, in Russia, nella Francia meridionale accanto alle forze germaniche della Wehrmacht. Ma, soprattutto, non bisogna parlare di foibe e di esodo, perché nessun paese vincitore ha migliaia di cittadini uccisi e centinaia di migliaia di profughi “dopo” la fine delle ostilità. La vicenda della frontiera adriatica è la prova provata che l’Italia ha perso la guerra: le foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono il prezzo pagato alla sconfitta, con il paradosso di una guerra scatenata da tutta l’Italia fascista nel 1940 e una sconfitta pagata solo dagli Italiani che vivono sul confine nordorientale.
Come ha insegnato il filosofo britannico Aldous Leonard Huxley, i fatti non cessano di esistere solo perché vengono ignorati: essi sopravvivono al silenzio colpevole degli studiosi e alle rimozioni interessate dell’immaginario, e spesso si ripresentano all’improvviso, riscoperti da un documento d’archivio, da un ritrovamento casuale, da una testimonianza tardiva, e finiscono in questo modo per caricarsi di
significati impropri. Per troppo tempo di foibe e di esodo si è parlato in modo episodico e male, facendone terreno di contesa ideologica, per gli uni riferimento identitario in funzione anticomunista, per gli altri negazione o giustificazione dell’accaduto. Gli infoibati e gli esuli della frontiera adriatica non sono né di destra né di sinistra: sono italiani vittime della guerra scatenata nel 1940, che si sono trovati a vivere nel posto sbagliato nel momento sbagliato (con il particolare non indifferente che “quel posto” era casa loro).
La giornata del 10 febbraio è stata decisa nel 2004 con un voto quasi unanime del Parlamento per risarcire chi aveva subito un silenzio troppo profondo e, soprattutto, per immettere nel circuito della memoria nazionale la vicenda della frontiera adriatica. In questo saggio ben articolato e scientificamente fondato, Giovanni Stelli e Marino Micich fanno il punto a vent’anni dall’approvazione della legge. Non c’è dubbio che ancora oggi restano zone d’ombra, come dimostrano le polemiche pretestuose e fuori tempo che, nonostante tutto, sopravvivono. Ma è altrettanto indubbio che in vent’anni il clima è profondamente cambiato: il tema è stato sdoganato, i mass media (almeno
una volta l’anno) ne parlano, le televisioni hanno proposto documentari e telefilm, molte scuole hanno avviato specifici percorsi didattici, il Ministero dell’istruzione si è fatto carico di corsi di formazione per docenti, visite guidate, linee guide per la didattica; ai massimi livelli istituzionali, inoltre, ci sono stati momenti significativi, come il grande concerto della pace diretto da Riccardo Muti in piazza Unità a Trieste nel 2013, alla presenza dei presidenti di Italia, Slovenia e Croazia, nel 90° anniversario dell’assalto all’Hotel Balkan; o l’incontro tra Sergio Mattarella e il presidente sloveno Borut Pahor il 13 luglio 2020 alla foiba di Basovizza. La strada imboccata è quella giusta: a livello
internazionale l’obiettivo non è una memoria “condivisa”, ma memorie “riconosciute”, ognuna delle quali riconosca la legittimità dell’altra per comporre, insieme, un quadro superiore; a livello nazionale, la consapevolezza civico di quanto è accaduto, al di là delle “bandierine” di parte.
Perché quando accaduto sulla frontiera adriatica è un pezzo della storia d’Italia in una delle sue stagioni più drammatiche e sofferte.
Gianni Oliva